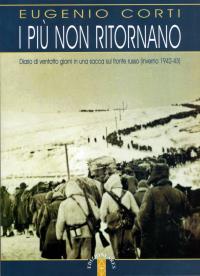L’introduzione di Luca Doninelli a I più non ritornano
1
Spesso si parla di letteratura quando la letteratura non c’è. Oppure c’è, ma si fa come se non ci fosse. Si può passare una vita a parlare di Dante o di Leopardi in loro assenza. A interpretarli. A mettere loro in bocca parole che sono soltanto nostre.
Già, «mettere in bocca». Che espressione sconsolata! Un vero scrittore non mette in bocca nessuna parola ai suoi personaggi, perché un vero scrittore sa che i personaggi non sono suoi, e che le loro parole sono le loro, e non le sue.
Ma un grande romanziere, se grande è, non lo si interpreta: lo si legge, e allora lo si capisce, lo si ama, lo si fraintende, e tutto questo capire e non capire entrerà a far parte del suo destino, del destino della sua opera, ne segnerà il percorso, la forma della sua fortuna, che per i grandi scrittori è diversa da persona a persona – così come è sempre uguale (mi spiace contraddire Tolstoj) la fortuna degli scrittori modesti: caso letterario, ottime recensioni, scalata in cima alle classifiche, saggi dedicati, saturazione, noia, dimenticanza.
2
La fortuna, o meglio il pezzo di fortuna toccato finora all’opera di Eugenio Corti dipende soprattutto dalla sua grandezza. Non penso, sinceramente, che l’essere stato osteggiato da una certa cultura laicista dominante, il fatto cioè di non essere piaciuto ai maggiorenti della cultura italiana, sia un elemento importante di questa storia. Non ho mai voluto verificare se questa ostilità ci sia o meno, perché a me queste cose interessano poco. Le innumerevoli ristampe e la diffusione planetaria di opere come Il cavallo rosso o delle terribili pagine de I più non ritornano dimostrano come l’avversione ideologica sia alle volte un bene. La repressione non ha mai ucciso la verità.
Certo, il fatto che un testimone oculare degli orrori della guerra in Russia sia tornato con una versione dei fatti che fa a pugni con il racconto ufficiale, quello che ha fatto da fondamento al nuovo mondo che stava per nascere, gli ha procurato molti nemici e molti silenzi, ma perché lagnarsi di questo?
Non è questo il destino di ogni vero scrittore?
Se lo scrittore non cercasse di dar voce allo strazio che il cemento dei diversi poteri cerca di seppellire come un reattore nucleare in avaria, a che servirebbe mai il suo lavoro?
Che soddisfazione può trarre uno scrittore al pensiero di aver ricevuto onori, posti in parlamento, premi, inchini, lodi universali?
Che piacere può trarre – se non un piacere arido, senza vita – uno scrittore dal pensiero che tutto l’odio seminato intorno a sé è stato tenuto sotto silenzio dalle convenienze politiche, dalla diplomazia della forza, dagli input del potere?
3
Esistono naturalmente molti scrittori «di regime» che sono, nondimeno, grandi scrittori, perché il talento ci vuole sempre, sia per opporsi al Pensiero Unico sia per edificarne il monumento.
Io però mi rifiuto di considerare Eugenio Corti una vittima di qualcosa. Andate a trovarlo, parlate cinque minuti con lui, e vi accorgerete che Eugenio Corti non è una vittima. Gli incontri personali che ho avuto con lui hanno sempre portato il segno di una forza vitale fuori del comune, e più d’una volta mi è capitato di pensare che tale doveva essere la sensazione per chi aveva la fortuna di incontrare Tolstoj, o Manzoni. Eugenio Corti non è mai stato seppellito né dai nemici né dagli amici adoranti – che in determinate circostanze possono essere anche peggio dei nemici. Non consideriamolo un ideologo anticomunista avversato dai comunisti: Eugenio Corti, qualunque sia il suo pensiero, è innanzitutto un grandissimo narratore.
Non mi occupo delle sue opinioni sull’ideologia. Non mi occupo della sua posizione sugli anni successivi al Concilio Vaticano II (che gli ha procurato diversi nemici anche dentro la sua amatissima Chiesa Cattolica). Su molte cose non la penso come lui, ma queste divergenze sono niente, sono come discutere del colore delle scarpe di uno scrittore. È del grande scrittore, e soprattutto del grande narratore, che bisogna cominciare a parlare.
4
Il mondo ha bisogno di narratori. Non di scrittori: di narratori. Non di racconti, ma di narrazioni. Il racconto è il prodotto di un soggetto (il mio racconto, il tuo racconto, e così via), la narrazione invece è qualcosa che esiste nel mondo, un grande fiume che raccoglie tutto quello che ci fa vivere o che ci uccide, la pena, il dolore ma anche la felicità improvvisa, o quello che i sociologi bugiardi chiamano «disagio», che non è altro che il grido che erompe dal cuore di chi sta dentro una baracca e non sa come dar da mangiare ai suoi figli, ma anche dal cuore di un ricco prigioniero della sua casa da sogno, della sua Ferrari, della sua indifferenza al modo in cui impiegherà il proprio tempo: lavorare, dormire, avere un flirt, fare del bene, non farlo… Che ne dite di un titolo come Il disagio del filantropo?
La narrazione è del tutto indifferente agli indirizzi del potere e al racconto che vuole imporre. Il racconto del potere è parte – una piccola parte – della grande narrazione del mondo, che ha come unico oggetto la verità dei fatti, la loro nudità: le versioni ufficiali non sono che un frammento, un fatterello dentro il grande flusso.
E i narratori sono i rabdomanti, coloro che, camminando sulla lastra di cemento – ossia di silenzio – che ci separa sempre (non ora: sempre) dalla verità dei fatti si soffermano là dove sentono che la lastra è più sottile, e praticano, con cautela ma anche con decisione, dei piccoli buchi, poi in quei buchi infilano una mano, poi un braccio, poi ci s’infilano tutti, e scendono giù, armati di una piccola luce (perché l’ingegno è quello che è, e anche l’uomo più intelligente è comunque un babbeo di fronte al Vero), e cominciano a esplorare, ben sapendo che quello che vedranno è sempre solo una piccola parte di quello che c’è.
5
Leggendo le opere di Eugenio Corti ho capito da cosa si riconosce un vero narratore. Non dalle opinioni dello stesso, non dalla lunghezza dei suoi libri, non dalla sua capacità di dipingere grandi affreschi (attenti agli affreschi, perché esistono anche gli affreschi della menzogna!), insomma non dalla sua capacità di dominio della pagina, ma solo dalla sua capacità di lasciar entrare dentro la pagina qualcosa che non coincide con lui, con il suo pensiero, con la sua abilità tecnica, con le sue tematiche, più o meno grandi (imbarazzo dei professori liceali quando, insieme a Leopardi tutto pieno di tematiche, tocca far studiare Foscolo e la sua grandezza senza tematiche). Penetrare nella grande narrazione del mondo, stando al cospetto del Vero, significa lasciar entrare Dio nelle proprie pagine.
Creda o non creda, professi o non professi a titolo personale (ossia riguardo a ciò che egli, come essere umano, crede di sapere di sé stesso), un vero grande narratore parla di Dio. Le vicende, storiche o fantastiche, da lui narrate ruotano intorno a questo dato (Dio è un dato, non un tema).
Ora, ciò che costituisce l’unicità dell’esperienza e della lezione letteraria di Eugenio Corti consiste, almeno secondo me, in questo: che Corti apre le sue opere mettendo in scena esattamente questo fattore determinante. Di norma, un narratore trova Dio lungo la strada, la sua apertura di cuore e di penna (il cuore, ahimé, non basta al duro lavoro degli artisti, almeno fino a che esso non coincide – duro, duro lavoro! – con lo strumento stesso del proprio fare) lo rendono più sensibile al vento dello spirito, da qualunque direzione venga (a differenza dello scrittore-ideologo, che accetta lo spirito solo se viene da una certa direzione). Ciò che in Eugenio Corti risulta per qualcuno irritante è la sua consapevolezza di questo procedimento: una consapevolezza tale che Dio campeggia, opportunamente camuffato, fin da subito.
Camuffato – questo è ovvio. Un vero narratore non può risparmiare al suo lettore la fatica e la gioia di un ritrovamento personale, di una personale illuminazione. Un vero narratore, come non mette in bocca le parole ai suoi personaggi, allo stesso modo non mette in cuore le emozioni ai suoi lettori.
6
Così, alla terza rilettura de Il cavallo rosso mi sono accorto che il piacere che ne ricevevo dipendeva dal piacere speciale – ancora indecifrabile le prime due volte, ma già presente – che mi davano le prime pagine del grande romanzo.
Improvvisamente, sullo sfondo lontano della Storia e delle sue «brutte possibilità» (Giussani) interamente presenti nel bubbolio che pervade quelle straordinarie pagine – che io associo sempre al meraviglioso e insieme spaventoso Primo Tempo della Sinfonia numero Sette «di Leningrado» di Dmitri Shostakovic – compaiono tre personaggi: un padre, un figlio e un cavallo rosso.
A differenza di Goethe, Corti non dichiara trattarsi di un Prologo in Cielo, ma alla terza lettura del capolavoro ho finalmente capito che il solo modo di osservare tutta l’immensa vicenda che scaturirà da quelle pagine è quello di tenere gli occhi fissi non sulla Storia (che a poco a poco finirebbe per coincidere con il caos, o con il trionfo della Legge del più forte), bensì su Chi della Storia è il Signore. Non un burattinaio, ma un cuore carico di pietà per i dolori incessanti che gli uomini recano agli uomini, per la crudeltà senza giustificazione (Auschwitz, i Gulag) e per quella che si giustifica facendosi passare per giustizia (Hiroshima, Dresda e la sicumera dei vincitori). Sullo sfondo dell’orrore, Dio e suo Figlio, insieme con lo Spirito, s’interrogano sul modo di mutare l’orrore in bene, e sanno – perché l’Onnipotenza di Dio è tale da coincidere perfino con la Sua Impotenza – che il dolore e il sangue non si potranno evitare, se si vuole che la Gloria di Dio si manifesti.
In quelle pagine ci sono il Genesi e l’Apocalisse, e noi comprendiamo bene che la scelta del modo in cui si racconta la Storia – se essa cominci con la Creazione e termini con il Giudizio Universale oppure cominci con i Sumeri e finisca con l’Unione Europea – non dipende soltanto dalle scelte ideologiche dello scrittore, ma anche da un criterio oggettivo di narrabilità.
La domanda è: quale contesto rende la Storia più narrabile, più obiettiva, meno soggetta a censure? La risposta (possibile secondo me anche a un non credente, purché sincero) è una sola: solo Dio non censura, solo Dio sa aprire la storia alla sua piena narrabilità, solo in Dio le contraddizioni del cuore diventano destino, e i dolori e perfino gli orrori aprono all’impossibile speranza, che è l’ultimo, il definitivo tra tutti i sentimenti umani: tolta all’uomo ogni cosa, perfino la capacità di amare, cosa gli resta, se non questa impossibile speranza? Credo quia absurdum non è una formula astratta: è la descrizione, la fenomenologia più esatta della nostra struttura ultima e della nostra esperienza umana.
In cielo, affacciati sulla terra, il volto segnato dalla pena, il Padre e il Figlio meditano sul dramma senza fine che non la cattiveria umana, ma il Loro stesso Amore hanno donato all’uomo. Come ricorda il misterioso canto quaresimale filippino: O cor soave / cor del mio Signore / ferito gravemente / non da coltel pungente / ma dallo stral che fabbricò l’Amore.
Dio non se ne sta beatamente seduto in un Olimpo a bere nettare e ambrosia, ma partecipa il mondo della Sua natura, che è drammatica. Chi dice che il Cristianesimo ha segnato la fine della Tragedia sbaglia: il Cristianesimo, e segnatamente la Risurrezione, è il culmine dell’esperienza tragica.
7
Perfino un diario terribile come I più non ritornano impone al lettore di rintracciare, per prima cosa, i termini della narrabilità degli eventi reali in esso riportati.
Leggendolo, vengono in mente l’ultimo Eliot con le sue parole irritanti («E il Figlio dell’Uomo non fu crocefisso una volta per tutte / il sangue dei martiri non fu versato una volta per tutte, / le vite dei Santi non vennero donate una volta per tutte (…). E se il Tempio dev’essere abbattuto / dobbiamo prima costruire il Tempio»), le immagini del Terzo Segreto di Fatima, e tutto quello che ci piacerebbe dimenticare.
Perché a tutti piacerebbe un Comunismo senza Gulag, una Resistenza senza foibe, un’America senza Hiroshima. Ma sarebbe una menzogna, anche se si capisce che evitare la menzogna significa guardare cose che ci farebbero girare d’istinto la testa da un’altra parte. I più non ritornano è pieno di cose che fanno girare la testa dall’altra parte, e Corti non prova nessun piacere sadico nel raccontarcele. Semplicemente, ci istruisce circa una possibilità nuova, quella di guardare l’orrore e raccontarlo, testimoniarlo, senza dover cadere nella disperazione, portando l’intelligenza umana fin sul margine di quell’impossibile speranza da cui scaturisce, finalmente incensurata, tutta la narrazione del mondo.
Ma l’esperienza umana arriva fino a quel punto solo se si spalanca al solo Soggetto in grado di abbracciarla tutta: quel Dio che, per rendere narrabile (e quindi non solo sopportabile ma perfino amabile tutta la Storia, anche nelle sue brutture) ha pregato il proprio unico Figlio di scendere, a cavallo di un cavallo rosso, a morire sulla nostra povera Terra.